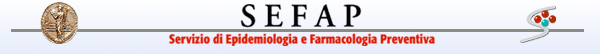|
DISPARITÀ
SOCIO-ECONOMICHE NELLA SALUTE IN 22 STATI EUROPEI
Le ineguaglianze nei servizi sanitari tra gruppi a diverso stato socioeconomico
costituiscono uno dei principali problemi della salute pubblica, ma non
è noto fino a che punto queste disparità siano modificabili.
Poiché gli studi di confronto tra gli stati possono aiutare l'identificazione
di possibili interventi, è stato condotto uno studio con l'intento
di misurare l'entità di tali disuguaglianze tra 22 stati europei,
utilizzando i dati sulla mortalità secondo i livelli di istruzione,
l'occupazione e le classi di reddito e le informazioni sull'auto-valutazione
dello stato di salute. I tassi di morte e di condizione sanitaria inadeguata
erano sostanzialmente più alti nei gruppi con stato socioeconomico
più basso; questa evidenza emergeva in tutti i Paesi, ma l'entità
delle differenze variavano da nazione a nazione; in particolare si è
osservata una situazione più omogenea negli stati dell'Europa meridionale,
mentre il divario maggiore è stato rilevato nelle regioni orientali
e baltiche.
[SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN HEALTH IN 22 EUROPEAN COUNTRIES. N Engl
J Med 2008; 358:2468-81]
ABSTRACT
IN INGLESE
CLASSE SOCIALE, FATTORI DI RISCHIO E INCIDENZA DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI
I tassi di morte CV sono calati sin dagli anni '70, anche se più
rapidamente nelle classi sociali più ricche, così la differenza
relativa tra i ceti più alti e quelli più bassi è
man mano aumentata. Questo studio ha indagato la relazione tra la classe
sociale e l'incidenza di CVD allo scopo di chiarire quanto questa associazione
fosse indipendente dai fattori di rischio CV tradizionali. Lo studio prospettico
ha seguito dal 1993-1997 al 2006 una popolazione di 22.478 uomini e donne
tra 39 e 79 anni. In entrambi i sessi si osservava una relazione inversa
tra la classe sociale e l'incidenza di CVD. L'aggiustamento per fattori
di rischio tradizionali (età, fumo, indice di massa corporea, pressione
sistolica, colesterolo totale, storia di diabete, attività fisica,
consumo di alcol e livelli di vitamina C) aveva poco effetto negli uomini,
mentre nelle donne l'associazione veniva attenuata. Lo strato sociale
più basso restava un fattore di rischio CV nei soggetti oltre i
65 anni.
[OCCUPATIONAL SOCIAL CLASS, RISK FACTORS
AND CARDIOVASCULAR DISEASE INCIDENCE IN MEN AND WOMEN: A PROSPECTIVE STUDY
IN THE EUROPEAN PROSPECTIVE INVESTIGATION OF CANCER AND NUTRITION IN NORFOLK
(EPIC-NORFOLK) COHORT. Eu J Epidemiol 2008; 23:449-458]
ABSTRACT
IN INGLESE
COMPORTAMENTO DI TIPO A E RISCHIO CORONARICO
La psicosomatica suddivide i comportamenti umani in due gruppi, definiti
Tipo A e Tipo B. Gli individui appartenenti al Tipo A sono caratterizzati
da aggressività, impazienza e difficoltà al rilassamento
e presentano una maggiore probabilità di soffrire di qualche disturbo
sia fisico che psichico dovuto alla pressione di eventi stressanti. Essi
sembrano essere molto vulnerabili nei confronti delle malattie coronariche
(CHD). Coloro che appartengono al Tipo B, invece, manifestano una più
elevata capacità di fronteggiare situazioni potenzialmente stressanti,
rendendo di conseguenza minore il rischio di ammalarsi. La differenza
tra le due tipologie dipende dal modo in cui viene organizzata la risposta
a situazioni di stress. Questo studio condotto su 86.361 giapponesi tra
i 40 e 69 anni non ha però riscontrato evidenze di un'associazione
tra comportamento di Tipo A e sviluppo di malattie coronariche, anzi tra
i soggetti maschi il comportamento di Tipo B sembra conferire un maggior
rischio di CHD.
[TYPE A BEHAVIOUR AND RISK OF CORONARY HEART DISEASE:
THE JPHC STUDY. IJE, pubblicato on line l'1 luglio 2008]
ABSTRACT
IN INGLESE
IL PARADOSSO DIABETE-RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Il diabete è un noto fattore di rischio coronarico ed aumenta la
mortalità in seguito ad eventi coronarici acuti. È stato
mostrato recentemente che la mortalità per malattie cardiovascolari
(CVD) e coronariche (CHD) tra soggetti non diabetici è in continua
riduzione, mentre non diminuisce tra i diabetici. Così, l'aumento
dell'incidenza di diabete in molte popolazioni può portare ad una
stabilizzazione della riduzione della mortalità coronarica. Questo
è il "paradosso diabete - rischio cardiovascolare". Scopo
dello studio era valutare e confrontare i tassi di eventi coronarici e
di mortalità tra diabetici e non diabetici in due coorti (complessivamente,
16.779 uomini e 18.235 donne) arruolate a distanza di 10 anni e seguite
per altri 10. Il rischio di eventi CV nelle donne non cambiava tra le
due coorti, mentre negli uomini diabetici di tutte le età e in
quelli non diabetici tra 25 e 49 anni mostrava un decremento nella coorte
più recente. Il rischio di mortalità per CHD era superiore
negli uomini diabetici, mentre i tassi di eventi coronarici e di mortalità
si riducevano nei non diabetici.
[THE DIABETES-CARDIOVASCULAR RISK PARADOX: RESULTS
FROM A FINNISH POPULATION-BASED PROSPECTIVE STUDY. Eur Heart J, pubblicato
on line il 16 giugno 2008]
ABSTRACT
IN INGLESE
CONSUMO DI CAFFÈ E MORTALITÀ
Molti studi epidemiologici hanno esaminato il consumo di caffé
e il rischio di malattie coronariche o altre patologie croniche, ma i
dati relativi alla mortalità specifica o per tutte le cause sono
discordanti. Scopo di questo studio era valutare l'associazione tra l'assunzione
di caffé e la mortalità per tutte la cause, cardiovascolare
e per cancro. Il follow-up prolungato e l'utilizzo di rilevazioni dei
consumi e di misurazione dei fattori di rischio ripetute ha permesso di
ottenere dati esaustivi sull'effettivo consumo di caffé e di controllare
i risultati per potenziali fattori confondenti. Sono stati coinvolti 41.736
uomini e 86.214 donne (Health Professionals Follow-up Study e Nurses'
Health Study). I risultati hanno screditato l'ipotesi di un'associazione
con i tassi di mortalità in entrambi i sessi; al contrario, è
stata osservata una correlazione inversa tra consumo di caffé e
mortalità CV e per tutte le cause, che necessita di indagini più
approfondite.
[THE RELATIONSHIP OF COFFEE CONSUMPTION WITH MORTALITY.
Ann Intern Med 2008; 148:904-14]
ABSTRACT IN INGLESE
VITAMINA D E RISCHIO DI INFARTO MIOCARDICO E MORTALITÀ CARDIOVASCOLARE
E PER TUTTE LE CAUSE
Un nuovo studio suggerisce un legame tra bassi livelli di vitamina D e
rischio cardiaco e mostra l'associazione tra deficit di vit. D e mortalità
cardiovascolare e per tutte le cause. E' stato stimato che nel 50-60%
della popolazione si osservano livelli insufficienti di questa sostanza
e ciò è probabilmente correlato a fattori come l'urbanizzazione,
i cambiamenti demografici, la riduzione dell'attività all'aperto,
l'inquinamento atmosferico. I valori minimi desiderabili di vit. D sono
stimati a 20-30 ng/mL e livelli più bassi sono chiaramente correlati
alla compromissione della densità minerale ossea, a fratture e,
più recentemente, al cancro ed a disordini immunitari, oltre a
malattie cardiovascolari, ipertensione e sindrome metabolica. Nello studio
caso-controllo condotto su 18.225 uomini dell'Health Professionals
Follow-up Study i livelli intermedi (15-30 ng/mL) e bassi (<15
ng/mL) di vit. D erano indipendentemente associati ad un rischio di infarto
miocardico 1,5-2 volte maggiore, anche dopo aggiustamento per diversi
fattori di rischio e condizioni correlate. Lo studio caso controllo di
3258 pazienti provenienti dalla coorte del LURIC study ha mostrato mostrano
che i pazienti nel quartile inferiore di vit. D al basale (mediana 13,3
ng/dL) avevano un rischio significativamente più alto di morte
per tutte le cause (HR 1,53; IC al 95% 1,17-2,01) e per cause CV (HR 1,82;
1,29-2,58).
[25-HYDROXYVITAMIN D AND RISK OF MYOCARDIAL INFARCTION
IN MEN: A PROSPECTIVE STUDY. Arch Intern Med 2008; 168:1174-80]; INDEPENDENT
ASSOCIATION OF LOW SERUM 25-HYDROXYVITAMIN D AND 1,25-DIHYDROXYVITAMIN
D LEVELS WITH ALL-CAUSE AND CARDIOVASCULAR MORTALITY. Arch Intern Med
2008; 168:1340-1349]
ABSTRACT 1 E
ABSTRACT 2 IN INGLESE
INDICE CAVIGLIA-BRACHIALE E FRAMINGHAM RISK SCORE PER PREDIRE EVENTI E
MORTALITÀ CV
La misurazione dell'indice caviglia-brachiale (ankle-brachial index,
ABI) può migliorare l'accuratezza della predizione del rischio
cardiovascolare con Framingham risk score e il suo utilizzo è favorito
dalla semplicità della procedura di rilevazione. E' stata condotta
una metanalisi di 16 studi di coorte con base di popolazione in cui l'ABI
veniva misurato al basale in 24.955 uomini e 23.339 donne. I risultati
hanno mostrato che un ABI uguale o inferiore a 0,90 prediceva l'aumento
del rischio di morte CV a dieci anni in entrambi i sessi. Il rischio rimaneva
elevato dopo aggiustamento per il Framingham risk score. L'inclusione
di ABI nella stratificazione del rischio ottenuta con il Framingham risk
score potrebbe portare alla ridefinizione delle categorie di rischio e
alla modifica delle raccomandazioni terapeutiche rispettivamente nel 19%
e nel 36% degli uomini e delle donne, anche se queste proporzioni possono
cambiare considerevolmente con l'età, poiché la prevalenza
di un basso ABI si riduce nei soggetti anziani.
[ANKLE BRACHIAL INDEX COMBINED WITH FRAMINGHAM RISK
SCORE TO PREDICT CARDIOVASCULAR EVENTS AND MORTALITY. A META-ANALYSIS.
JAMA 2008; 300:197-208]
ABSTRACT
IN INGLESE
TERAPIA CON ESTROGENI E USO DELLA LIPOPROTEINA(a) NELLA PREDIZIONE DEL
RISCHIO CV
L'utilità della lipoproteina(a) nella predizione del rischio di
future patologie cardiache è fortemente attenuata nelle donne in
terapia ormonale. Lo studio ha analizzato i dati dal Women's Health
Study di 27.736 donne apparentemente sane di almeno 45 anni, seguite
per 13 anni di follow-up. 12.075 donne assumevano la terapia ormonale
al momento dell'arruolamento. I risultati hanno mostrato che i valori
di Lp(a) erano più bassi tra le donne trattate con ormoni. Alti
livelli del biomarker erano fortemente correlati al rischio di CVD future
solo nelle donne non in terapia ormonale. I ricercatori hanno proposto
almeno due spiegazioni: una riguarda l'interazione biologica tra i livelli
plasmatici di Lp(a) e l'uso di ormoni, l'altra considera la terapia ormonale
come un determinante surrogato di uno stile di vita salutare, che contrasta
l'effetto dannoso del biomarker lipidico sulla patologia cardiaca. Nell'editoriale
di accompagnamento si sottolinea che, nonostante le caratteristiche che
la accomunano al colesterolo LDL, la lipoproteina (a) ha una distribuzione
molto più simmetrica e solo una minoranza di soggetti presenta
valori correlabili al rischio CV. Questo, oltre alla difficoltà
nella standardizzazione delle misurazioni, può rendere problematico
il suo utilizzo nella previsione del rischio.
[LIPOPROTEIN(a), HORMONE REPLACEMENT THERAPY, AND
RISK OF FUTURE CARDIOVASCULAR EVENTS. J Am Coll Cardiol 2008; 52:124-131];
[ROLE OF LIPOPROTEIN(a) IN CARDIOVASCULAR DISEASE. CURRENT AND FUTURE
PERSPECTIVES. J Am Coll Cardiol 2008; 52:132-134]
ABSTRACT
IN INGLESE
CAPACITÀ PREDITTIVA DELLA PROTEINA C-REATTIVA IN PAZIENTI CON SINDROME
CORONARICA ACUTA
Un nuovo studio prospettico ha mostrato che la misurazione della proteina
C-reattiva (PCR) nei pazienti con sindrome coronarica acuta (ACS) ha un'importanza
limitata poiché questo marker non predice il rischio di futuri
eventi coronarici in maniera indipendente. La rilevazione della PCR al
momento del ricovero, alla dimissione e dopo 30 giorni non è in
grado di predire il rischio di morte, infarto miocardico (IM) o angina
instabile ad un anno, suggerendo la necessità di trovare altri
parametri predittivi nei pazienti con ACS. I ricercatori hanno arruolato
1210 pazienti con diagnosi di IM o angina instabile e hanno misurato i
livelli di PCR in tre tempi successivi. Le rilevazioni effettuate all'ammissione
e un mese dopo la dimissione avevano una modesta capacità di predire
l'occorrenza dell'evento ad un anno che tuttavia si azzerava dopo correzione
per altre variabili cliniche.
[CLINICAL UTILITY OF C-REACTIVE PROTEIN MEASURED
AT ADMISSION, HOSPITAL DISCHARGE, AND 1 MONTH LATER TO PREDICT OUTCOME
IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY DISEASE. THE RISCA (RECURRENCE AND INFLAMMATION
IN THE ACUTE CORONARY SYNDROMES) STUDY. J Am Coll Cardiol 2008; 51:2339-46]
ABSTRACT IN INGLESE
EMOGLOBINA GLICATA E PREDIZIONE DI EVENTI CORONARICI
Una delle variabili usate per calcolare il Framingham risk score è
la variabile dicotomica per la presenza di diabete mellito. Questo approccio
non tiene conto dell'aumento del rischio associato ad elevati livelli
di glucosio al di sotto della soglia diagnostica per il diabete o a quello
derivante da una glicemia molto alta nei pazienti diabetici. L'emoglobina
glicata (HbA1c) ha mostrato di predire gli eventi CV e la mortalità
per tutte le cause indipendentemente dagli altri fattori di rischio sia
nei diabetici che nei non diabetici. Sebbene non approvata per la diagnosi
di diabete, questo parametro è facilmente misurabile e correlabile
con la glicemia. Per valutare se l'aggiunta della misurazione di HbA1c
potesse migliorare la predizione del rischio di malattie coronariche,
sono stati studiati 10.295 soggetti reclutati nell'European Prospective
Investigation of Cancer-Norfolk (EPIC-Norfolk). I risultati hanno
mostrato che l'utilizzo di HbA1c in aggiunta al calcolo del Framingham
risk score comporta un piccolo ma significativo miglioramento negli uomini,
ma non nelle donne, e non determina una più precisa classificazione
delle categorie di rischio.
[EVALUATION OF THE FRAMINGHAM RISK SCORE IN THE EUROPEAN
PROSPECTIVE INVESTIGATION OF CANCER-NORFOLK COHORT: DOES ADDING GLYCATED
HEMOGLOBIN IMPROVE THE PREDICTION OF CORONARY HEART DISEASE EVENTS? Arch
Intern Med 2008; 168:1209-16]
ABSTRACT
IN INGLESE
ALTI LIVELLI DI ALBUMINURIA E IPERTENSIONE
Gli individui con alti livelli di escrezione di albumina, pur entro il
range considerato normale, hanno un rischio più alto di sviluppare
ipertensione; questa evidenza ha portato i ricercatori a suggerire la
necessità di una nuova definizione di "normalità"
dei valori di albuminuria. In questo studio sono stati analizzati i dati
relativi a 2179 pazienti a basso rischio, senza ipertensione al basale
e con livelli normali di albumina urinaria (<30 mg/giorno), arruolati
nelle due coorti del Nurses' Health Study (NHS). Tra le donne anziane
in post-menopausa nel NHS 1, quelle con i livelli più alti di escrezione
di albumina avevano il 76% di probabilità in più di sviluppare
ipertensione rispetto a quelle con livelli più bassi, mentre tra
le donne giovani del NHS 2 la probabilità era più alta del
35%.
[HIGHER LEVELS OF ALBUMINURIA WITHIN THE NORMAL RANGE
PREDICT INCIDENT HYPERTENSION. J Am Soc Nephrol 2008]
ABSTRACT IN INGLESE
COLESTEROLO HDL E CAPACITÀ MNEMONICHE
Un nuovo studio suggerisce che bassi livelli di colesterolo HDL in soggetti
di mezza età possano essere associati allo sviluppo di demenza
in età avanzata. Il C-HDL è un fattore critico per la maturazione
delle sinapsi e per il mantenimento della loro plasticità; può
influenzare la formazione di amiloide, il componente delle placche proteiche
riscontrate nel cervello dei malati di Alzheimer. In questo studio è
stata analizzata la relazione tra livelli lipidici e memoria a breve termine
in 3673 partecipanti al Whitehall II study. I risultati hanno mostrato
che, rispetto a soggetti con C-HDL >60 mg/dL, quelli con valori <40
mg/dL avevano maggiori probabilità di soffrire di deficit mnemonici;
l'associazione era indipendente dalla presenza dell'allele apoE4, un potente
fattore di rischio per l'Alzheimer, e non differiva tra uomini e donne.
Nell'editoriale di accompagnamento si sottolinea il fatto che, sebbene
siano molti gli studi che confermano questa correlazione, nessuno suggerisce
un rapporto di causalità, poiché i livelli lipidici plasmatici
possono cambiare considerevolmente durante lo sviluppo della demenza e
il momento della misurazione è un fattore di importanza critica.
[LOW HDL CHOLESTEROL IS A RISK FACTOR FOR DEFICIT
AND DECLINE IN MEMORY IN MIDLIFE. THE WHITEHALL II STUDY. Arterioscler
Thromb Vasc Biol, pubblicato on line il 30 giugno 2008]
ABSTRACT IN INGLESE
AREE VERDI E SALUTE: IL RUOLO DELL'ATTIVITÀ FISICA
Negli ultimi tempi è stata posta una crescente attenzione alla
relazione tra spazi verdi nel contesto in cui si vive e il benessere di
una persona. Molti studi hanno mostrato che un ambiente più naturale
ha un effetto positivo sulla percezione della salute e porta ad una riduzione
del rischio di mortalità. Tuttavia, sono scarse le conoscenze sull'entità
dell'effetto e sui meccanismi sottostanti. In questo studio è stata
indagata l'attività fisica come possibile fattore esplicativo di
tale relazione. Sono stati inclusi 4.899 olandesi, dei quali sono stati
raccolti dati su attività fisica, percezione dello stato di salute,
contesto demografico e socioeconomico. Nono sono state osservate relazioni
tra gli spazi verdi e l'aderenza dei soggetti alle raccomandazioni per
la promozione dell'attività fisica; i soggetti con a disposizione
aree verdi più vaste camminavano e andavano in bicicletta meno
di frequente, ma dedicavano più tempo al giardinaggio, anche se
questo non spiegava la relazione tra spazi verdi e salute.
[PHYSICAL ACTIVITY AS A POSSIBLE MECHANISM BEHIND
THE RELATIONSHIP BETWEEN GREEN SPACE AND HEALTH: A MULTILEVEL ANALYSIS.
BMC Public Health 2008; 8:206]
ABSTRACT
IN INGLESE
IL RISCALDAMENTO GLOBALE FA VENIRE I CALCOLI RENALI
Vi è una relazione fra il riscaldamento globale e l'incidenza dei
calcoli renali. Lo rivela uno studio pubblicato da Tom Brikowski del dipartimento
di Geologia dell'Università del Texas a Dallas, sulla rivista dell'Accademia
Americana delle Scienze 'PNAS'. Gli esperti hanno confrontato l'incidenza
dei calcoli renali con le temperature medie della zona chiamata in America
la 'cintura dei calcoli', ovvero il Sud-Est (Arkansas, Florida, Georgia,
Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee) dove
la malattia è molto diffusa, trovando un rapporto tra temperatura
ambientale e calcolosi. Poi hanno usato le 'mappe' del riscaldamento globale
dovuto ai gas serra, prodotte dall'Intergovernmental Panel on Climate
Change nel 2007, ed hanno stimato un considerevole aumento della calcolosi
in quelle regioni anche fino al 30% entro il 2050. Ma secondo gli esperti
questa situazione è estrapolabile anche al resto del mondo: il
punto è che la disidratazione è uno dei principali fattori
di rischio dei calcoli e il riscaldamento globale esacerberà questa
condizione. Più si riduce il volume delle urine, cosa che si verifica
con la disidratazione, più aumenta la formazione di calcoli renali.
[Fonte: SanitaNews.it. 14 luglio 2008]
|