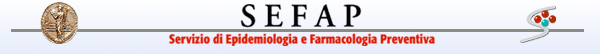|
PERSISTENZA
ALLA TERAPIA CON STATINE E MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE
Diversi trial randomizzati hanno documentato i benefici delle statine
sulla mortalità cardiovascolare in prevenzione secondaria, non
ci sono sufficienti evidenze in merito all'effetto sulla mortalità
totale in pazienti senza cardiopatia coronarica (CHD). Questo studio di
coorte retrospettivo ha valutato l'effetto delle statine nei soggetti
in prevenzione primaria e secondaria, arruolando 229.918 pazienti che
avevano iniziato un trattamento con statine tra il 1998 e il 2006. Durante
un follow-up medio di 4-5 anni si sono verificati 4.259 e 8.906 decessi,
rispettivamente, nella coorte in prevenzione primaria e in quella in prevenzione
secondaria. In entrambe le coorti la continuità del trattamento
con statine (percentuale di giorni coperti, PDC, >=90%) conferiva una
riduzione del 45% nella mortalità rispetto ai pazienti con PDC
<10%. Una riduzione superiore del rischio è stata calcolata
nei pazienti con elevati livelli basali di LDL e in quelli trattati inizialmente
con statine ad elevata efficacia.
[CONTINUATION OF STATIN TREATMENT AND ALL-CAUSE MORTALITY. Arch
Intern Med 2009; 169:260-268]
ABSTRACT
IN INGLESE
IPOLIPEMIZZANTI E MORTALITÀ IN SOGGETTI PRESUMIBILMENTE SANI
Sono state sollevate perplessità circa l'impatto degli ipolipemizzanti
sugli outcome non cardiovascolari poiché alcuni trial sull'efficacia
di questi farmaci non hanno mostrato una riduzione della mortalità,
nonostante il significativo effetto benefico sul rischio di morte cardiovascolare.
Inoltre, i dati pubblicati sul rischio di cancro correlato a queste terapie
sono contrastanti. Questo studio ha confrontato la mortalità a
10 anni sulla base del quadro dislipidemico al basale (normolipidemici,
dislipidemici non trattati, dislipidemici in terapia con fibrati o con
statine) in una coorte di 7722 soggetti trattati con ipolipemizzanti.
In 10 anni sono stati registrati 416 decessi (il 53,1% per cancro e il
17,1% per cause cardiovascolari). Dopo aggiustamento per multivariate,
gli hazard ratio per la mortalità per tutte le cause erano 0,49
per i soggetti in statine, 0,65 per quelli in fibrati, e 0,76 per i normolipidemici,
rispetto ai dislipidemici non trattati. I dati dimostrano che la terapia
con statine o con fibrati è associata ad una significativa riduzione
della mortalità per tutte le cause.
[TEN-YEAR ALL-CAUSE MORTALITY IN PRESUMABLY HEALTHY SUBJECTS ON
LIPID-LOWERING DRUGS (FROM THE PROSPECTIVE EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF MYOCARDIAL
INFARCTION [PRIME] PROSPECTIVE COHORT). Am J Cardiol 2009; 103:381-6]
ABSTRACT
IN INGLESE
ANTAGONISTI BETA-ADRENERGICI E MORTALITÀ IN SOGGETTI CON INSUFFICIENZA
CARDIACA
I farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina (ACE inibitori/sartani)
hanno mostrato effetti favorevoli sulla morbidità e sulla mortalità
in pazienti affetti da scompenso e rappresentano la prima scelta terapeutica.
I trial clinici randomizzati hanno dimostrato in alcuni casi un effetto
benefico anche per i ß-bloccanti, in altri hanno fatto ipotizzare
un effetto di classe negativo. Il presente studio di coorte è stato
realizzato in 11.326 adulti sopravvissuti dopo ospedalizzazione per scompenso
cardiaco tra il 2001 ed il 2003, utilizzando i dati delle prescrizioni
di ß-bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ospedalizzazione e nei 12
mesi successivi. I risultati hanno mostrato che il tasso di mortalità
durante 12 mesi di follow-up variava in base all'esposizione ed al tipo
di ß-bloccante (atenololo 20,1/100 anni persona; metoprololo tartrato
22.8/100 anni persona; carvedilolo 17,7/100 anni persona; altri ß-bloccanti
21,9/100 anni persona; nessun trattamento 37,0/100 anni persona). Il rischio
aggiustato di morte è risultato pari a 1,16 (IC 95% 1,01-1,34)
per il metoprololo ed a 1,63 (1,44-1,84) per chi non assume ß-bloccanti,
se confrontato con l'atenololo. Rispetto all'atenololo, non si sono osservate
differenze significative di rischio per il carvedilolo (HR 1,16; 0,92-1,44)
anche dopo aver aggiustato per i vari fattori di confondimento.
[COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT BETA-ADRENERGIC ANTAGONISTS
ON MORTALITY AMONG ADULTS WITH HEART FAILURE IN CLINICAL PRACTICE. Arch
Intern Med 2008; 168: 2415-21]
ABSTRACT
IN INGLESE
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ASPETTATIVA DI VITA NEGLI STATI UNITI
L'inquinamento atmosferico cittadino può ridurre del 15 per cento
le aspettative di vita. I risultati di questo studio indicano che una
riduzione di 10 microgrammi per metro cubo di particolato incrementerebbe
le aspettative di vita di circa sette mesi; questo miglioramento era ampiamente
indipendente dalla variabilità di fattori demografici, socio-economici
o correlati al fumo. Per analizzare l'impatto dello smog sull'aspettativa
di vita sono stati studiati i dati di 51 città statunitensi tra
il 1980 e il 2000; la ricerca si è concentrata in particolar modo
sul PM 2.5, prodotto prevalentemente dal traffico automobilistico. Dall'analisi
è emerso che al diminuire dei livelli di particolato aumentava
la durata della vita media dei cittadini. Il legame tra inquinamento e
aspettative di vita è risultato più marcato in quelle città
dove si è riusciti ad ottenere un abbassamento considerevole dello
smog.
[FINE-PARTICULATE AIR POLLUTION AND LIFE EXPECTANCY IN THE UNITED
STATES. N Engl J Med 2009; 360:376-386]
ABSTRACT
IN INGLESE
RIDUZIONE DELLA GRAVITÀ DEGLI INFARTI MIOCARDICI, 1987-2002
La gravità degli infarti miocardici è notevolmente diminuita
negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni, come mostra una nuova analisi
dallo studio ARIC. Questa evidenza, probabile conseguenza di un miglior
controllo di fattori di rischio come la pressione arteriosa e il colesterolo,
ha verosimilmente contribuito alla riduzione dei tassi di morte per CHD.
Questa nuova indagine estende precedenti risultati dall'ARIC nel periodo
1987-1994, avendo osservato 10.285 pazienti tra 35 e 74 anni, dimessi
dall'ospedale con diagnosi di certo o probabile primo attacco cardiaco
tra il 1987 e il 2002. La classificazione dell'infarto miocardico è
stata effettuata seguendo un algoritmo basato su dolore al petto, caratteristiche
dell'ECG e biomarker cardiaci. Il numero di casi con anormalità
dell'ECG si riduceva dell'1,9%/anno (p=0,002) per quanto riguarda l'iniziale
elevazione del segmento ST, del 3,9% (p<0,001) in caso di conseguenti
onde Q e del 4,5% (p<0,001) in caso di onde Q maggiori. Anche i valori
massimi di creatina chinasi e di creatina chinasi MB diminuivano (del
5,2% e del 7,6%; p<0,001 e p<0,001 per anno, rispettivamente), sebbene
nengli anni successivi i valori massimi di troponina I rimanessero stabili.
[DECLINING SEVERITY OF MYOCARDIAL INFARCTION FROM 1987 TO 2002.
THE ATHEROSCLEROSIS RISK IN COMMUNITIES (ARIC) STUDY. Circulation, pubblicato
on line il 19 gennaio 2009]
ABSTRACT
IN INGLESE
VARIAZIONE CROMOSOMICA DI 9P21.3 E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
I risultati di un ampio studio prospettico su donne bianche ha mostrato
che la valutazione del rischio cardiovascolare in base alla variante genotipica
9p21.3, associata allo sviluppo di patologie copronariche, non aumenta
il potere predittivo dei tradizionali fattori di rischio. Sono state studiate
22129 donne partecipanti al Women's Genome Health Study, inizialmente
senza evidenza di malattie croniche. E' stata effettuata la genotipizzazione
per il polimorfismo rs10757274 su 9p21.3 e la misurazione dei tradizionali
fattori di rischio, quali pressione arteriosa, diabete, fumo, livelli
plasmatici, storia familiare di infarto miocardico prematuro. L'analisi
ha mostrato un'associazione significativa tra i genotipi AG e GG e il
rischio di CVD incidenti (hazard ratios 1,32-1,63, rispetto al genotipo
AA). Tuttavia, l'aggiunta del genotipo al tradizionale modello predittivo
comportava uno scarso miglioramento.
[CARDIOVASCULAR DISEASE RISK PREDICTION WITH AND WITHOUT KNOWLEDGE
OF GENETIC VARIATION AT CHROMOSOME 9P21.3. Ann Intern Med 2009; 150: 65-72]
ABSTRACT
IN INGLESE
A CONFRONTO LE PROGNOSI DI DIABETE MELLITO DI TIPO 2 E DI MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
Il razionale di questo studio era rappresentato dalla necessità
di maggiori informazioni circa la prognosi cardiovascolare di uomini diabetici
in relazione a soggetti con CVD. I ricercatori hanno ipotizzato che la
prognosi avversa associata alla diagnosi di diabete sia simile a quella
associata alla diagnosi di patologie cardiovascolari sul lungo termine,
ma abbastanza differente se valutata sul breve termine. La popolazione
in studio era composta da 4376 canadesi di 35-64 anni senza CVD nel 1974
e seguiti fino al 1998. Durante il periodo di osservazione sono stati
documentati 137 nuovi casi di diabete in soggetti senza CVD e 527 CVD
in soggetti non diabetici. Questi casi, appaiati per età ad altrettanti
controlli, mostravano una più alta mortalità cardiovascolare
(rischio relativo aggiustato per età 3,11; IC al 95% 1,96-4,92
per i diabetici e 4,46; 3,15-6,30 per quelli con CVD). Tuttavia, nei primi
5 anni dopo la diagnosi, gli uomini con CVD avevano una mortalità
cardiovascolare maggiore a quella dei pazienti diabetici (RR 2,03; 1,01-4,08).
[COMPARISON OF PROGNOSIS FOR MEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND
MEN WITH CARDIOVASCULAR DISEASE. CMAJ 2009; 180:40-7]
ABSTRACT
IN INGLESE
DIABETE E RISCHIO DI DEMENZA
Uno studio con base di popolazione effettuato su 13.693 gemelli ha mostrato
che il diabete aumenta il rischio di demenze, specie se lo sviluppo della
patologia avviene in mezza età: l'analisi ha rivelato cha la comparsa
di diabete prima dei 65 anni è associato ad un aumento del rischio
di morbo di Alzheime del 125%. Le osservazioni effettuate sui gemelli
consentono di verificare l'associazione già ipotizzata tra diabete
e demenze e valutare l'influenza di fattori genetici e ambientali. Nel
campione sono stati riscontrati 467 casi di demenze (292 con morbo di
Alzheimer, 105 con demenza vascolare e 70 con altri tipi) e 120 casi di
diagnosi dubbia. Il diabete di tipo 2, riscontrato in 1396 soggetti, era
associato ad un moderato aumento del rischio di demenza (odds ratio 2,17;
IC al 95% 1,36-3,47). Questi risultati sottolineano l'importanza di esercizio
fisico, dieta, astensione dal fumo e controllo glicemico nei diabetici
in termini di rischio di demenze.
[MID- AND LATE-LIFE DIABETES IN RELATION TO THE RISK OF DEMENTIA:
A POPULATION-BASED TWIN STUDY. Diabetes 2009; 58:71-7]
ABSTRACT
IN INGLESE
SINDROME METABOLICA E MORTALITÀ CARDIOVASCOLARE NELLA POPOLAZIONE
ITALIANA ANZIANA
Gli effetti della sindrome metabolica (SM) negli anziani rappresentano
un problema clinico cruciale a causa della crescita della popolazione
anziana in tutto il mondo e dell'aumento della prevalenza di SM con l'età.
Questo studio ha indagato l'associazione tra SM, complessivamente o per
i singoli determinanti, e mortalità cardiovascolare e per tutte
le cause in una popolazione italiana di 2910 soggetti con più di
65 anni (Progetto Veneto Anziani, Pro.V.A.) seguita mediamente per 4,4
anni. La SM (diagnosticata secondo i criteri NCEPT III) era significativamente
associata ad aumento della mortalità per tutte le cause in tutti
i soggetti (hazard ratio 1,41), negli uomini (1,42) e nelle donne (1,47).
Dopo aggiustamento per multivariate, SM era anche associata ad una umento
della mortalità CV in tutti i soggetti (1,60), negli uomini (1,66)
e nelle donne (1,60). L'elevata glicemia in tutti i soggetti e nelle donne
e bassi livelli di HDL nelle donne erano predittori indipendenti di mortalità
per tutte le cause e cardiovascolare.
[METABOLIC SYNDROME AND ALL-CAUSE AND CARDIOVASCULAR MORTALITY IN
AN ITALIAN ELDERLY POPULATION: THE PROGETTO VENETO ANZIANI (PRO.V.A.)
STUDY. Diabetes Care 2009; 32:153-9]
ABSTRACT
IN INGLESE
INDICE DI MASSA CORPOREA E MORTALITÀ
E' ancora acceso il dibattito circa il ruolo dell'indice di massa corporea
(IMC) come fattore di rischio di mortalità per tutte le cause.
Questo studio ha indagato tale associazione in una corte austriaca di
184.697 uiomini e donne seguiti mediamente per 15,1 anni. Durante il follow-up
sono state registrate 15.557 morti (6077 per cause CV, 4443 per cancro
e 606 per patologie respiratorie). L'IMC mostrava un'associazione a U
con la mortalità per tutte le cause. Rispetto alla categoria di
riferimento (IMC 22,5-24,9 kg/m²) si osservava un maggior rischio
sia nella classe di IMC più alta (>=35 kg/m2) con hazard ratio
(HR) di 2,13 negli uomini e di 1,60 nelle donne, sia in quella più
bassa (<18,5 kg/m²), con HR di 2,57 negli uomini e di 1,40 nelle
donne. Un andamento silime è stato riscontrato per i non fumatori.
L'aumento della mortalità con l'IMC dipende essenzialmente dai
decessi per cause CV, in minor misura dai casi di cancro.
[BODY MASS INDEX AND MORTALITY: RESULTS OF A COHORT OF 184,697 ADULTS
IN AUSTRIA. Eur J Epidemiol 2009; 24:83-91]
ABSTRACT
IN INGLESE
CONSUMO DI CAFFÈ E RISCHIO DI ICTUS NELLE DONNE
Una nuova analisi dal Nurses' Health Study mostra che il consumo a lungo
termine di caffè (fino a quattro tazzine al giorno) non è
associato all'aumento del rischio di ictus, anzi sembra essere protettivo
nell donne non fumatrici. Tra le fumatrici non sembra esserci effetto
del consumo di caffè, ne positivo né negativo, sul rischio
di ictus. Non sono state osservate associazioni con altre bevande a base
di caffeina, mentre il caffè decaffeinato mostrerebbe un effetto
protettivo. In questo studio sono state analizzate 83.076 donne senza
storia di ictus, coronaropatie, diabete o cancro al basale; il consumo
di caffè è stato rilevato periodicamente durante tutto il
follow-up (24 anni). In questo periodo si sono verificati 2280 ictus;
dopo aggiustamento per fattori come età, fumo, indice di massa
corporea, attività fisica, consumo di alcolici, menopausa, terapia
ormonale, uso di aspirina e fattori dietetici, non è stato osservato
un aumento del rischio di ictus associato al consumo di caffè,
mentre ne è stato evidenziato l'effetto protettivo, per 4 tazzine
al giorno (rischio relativo 0,80; IC al 95% 0,64-0,98).
[COFFEE CONSUMPTION AND RISK OF STROKE IN WOMEN. Circulation, pubblicato
on line il 16 febbraio 2009]
ABSTRACT
IN INGLESE
|