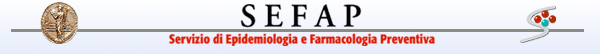|
BLOCCANTI
DEI CANALI DEL CALCIO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI PARKINSON
Nella ricerca di agenti neuroprotettivi, recenti studi su roditori
o primati hanno mostrato promettenti risultati con ACE-inibitori e bloccanti
dei canali del calcio, inclusa una riduzione della perdita, indotta sperimentalmente,
di neuroni dopaminergici a livello striatale. In questo studio i ricercatori
hanno usato i dati dal General Practice Research Database, contenenti
informazioni su più di 5 milioni di assistiti di medicina generale
in Gran Bretagna, per disegnare un'analisi caso-controllo retrospettiva
che esaminasse le possibili relazioni tra l'uso di farmaci antipertensivi
e il rischio di sviluppare Parkinson (PD). Sono stati identificati 3637
casi e un ugual numero di controlli (40% donne). I risultati suggeriscono
che l'uso a lungo termine (più di 30 prescrizioni) di bloccanti
dei canali del calcio, ma non di altri agenti antipertensivi, è
associato ad una significativa riduzione del rischio di Parkinson (OR
0,77; IC al 95% 0,63-0,95). L'effetto era più alto nelle donne
e nei soggetti al di sopra di 80 anni d'età.
[USE OF ANTIHYPERTENSIVES AND THE RISK OF PARKINSON DISEASE.Neurology,
pubblicato on line il 6 febbraio 2008]
FARMACI
PER LE OSSA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI FRATTURE DA OSTEOPOROSI
Le evidenze scientifiche sull'efficacia dei farmaci per le ossa sono
ampiamente convincenti; tuttavia, i tassi di trattamento nei pazienti
a rischio e l'aderenza alla terapia rimangono scarsi. Questo studio aveva
lo scopo di valutare se l'esposizione a tali farmaci fosse associata ad
una riduzione del rischio di fratture in un sottogruppo della popolazione
femminile. Sono stati quindi condotti due studi caso-controllo, arruolando
3170 donne con età >=70 anni (1824 con osteoporosi e 1346 con
precedente frattura) e appaiando ogni caso con 10 controlli. L'effetto
dei farmaci per le ossa sulla riduzione del rischio di fratture era significativo
nel caso dell'osteoporosi (-16% per tutti i tipi di fratture e -39% per
fratture spinali, dell'anca e del polso) ma non in caso di precedente
frattura.
[POPULATION-BASED STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF BONE-SPECIFIC
DRUGS IN REDUCING THE RISK OF OSTEOPOROTIC FRACTUREY. Pharmacoepidemiol
Drug Saf, pubblicato on line il 23 gennaio 2008]
FATTORI
DI RISCHIO PER LE FRATTURE IN DONNE IN MENOPAUSA CON OSTEOPOROSI
La densità minerale ossea (bone mineral density, BMD)
è utilizzata per la diagnosi di osteoporosi. Sebbene un valore
basso indichi rischio di fratture, questo indice usato da solo non è
particolarmente sensibile. Sulla base dei limiti della BMD e del riconoscimento
di altre caratteristiche associate alle fratture, l'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha identificato 8 fattori clinici di rischio (CRF):
età, fratture precedenti, BMD del collo del femore (o IMC in assenza
di misure della BMD), uso passato o attuale di corticosteroidi, storia
familiare di fratture, fumo, consumo di almeno due bicchieri di alcolici
al giorno e osteoporosi secondaria associata a disordini come l'artrite
reumatoide. Questa review di 68 studi ha valutato l'associazione tra 5
di questi fattori e il rischio di osteoporosi; inoltre ha focalizzato
l'attenzione sul rischio nelle donne in menopausa. Dai risultati è
emerso che una precedente frattura e una deviazione standard di BMD al
di sotto della media di riferimento erano associate ad un rischio più
alto di 18 e 4 volte, rispettivamente: questi due fattori costituiscono
i migliori predittori di rischio di osteoporosi.
[CLINICAL RISK FACTORS FOR FRACTURE IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROTIC
WOMEN: A REVIEW OF THE RECENT LITERATURE. Ann Pharmacother, pubblicato
on line il 29 gennaio 2008]
|
|
RUMORE
NOTTURNO E PRESSIONE ARTERIOSA
Nuove ricerche dallo studio Hypertension and Exposure to Noise
Near Airports (HYENA), che ha associato gli effetti del rumore
notturno alla pressione arteriosa, hanno osservato che le persone residenti
nei pressi di aeroporti manifestano aumenti pressori acuti e cronici in
risposta al rumore degli aerei. Una nuova analisi suggerisce che picchi
di pressione si registrano anche in caso di rumori di altra natura. I
risultati rivelano che il rischio di ipertensione aumenta parallelamente
all'esposizione ad inquinamento acustico a lungo termine. L'analisi è
stata condotta su circa 5000 soggetti che vivevano vicino a 6 tra i principali
aeroporti europei. È stato riportato un aumento medio della pressione
sistolica di 6,2 mm Hg e della diastolica di 7,4 mm Hg entro 15 minuti
da ogni forte rumore prodotto dagli aeroplani, ma anche altre fonti sonore,
come il traffico, producevano picchi nei valori pressori. E' interessante
notare che i livelli acustici studiati in questa analisi sono a volte
al di sotto di quelli necessari a provocare il risveglio.
[ACUTE EFFECTS OF NIGHT-TIME NOISE EXPOSURE ON BLOOD PRESSURE
IN POPULATIONS LIVING NEAR AIRPORTS. Eur Heart J, pubblicato on line il
12 febbraio 2008]; [HYPERTENSION AND EXPOSURE TO NOISE NEAR AIRPORTS:
THE HYENA STUDY. Environ Health Perspect 2008; 116:329-333]
BIOMARKER
PROTEOMICI URINARI E CORONAROPATIA
È
stato ipotizzato che l'analisi delle urine possa fornire un quadro utile
per la diagnosi e il monitoraggio delle arteriopatie coronariche (CAD).
I ricercatori hanno esaminato 359 campioni di urina da 88 pazienti con
grave coronaropatia e 282 controlli e, usando uno spettrometro di massa,
hanno identificato più di 1000 polipeptidi per campione. Lo studio
ha inizialmente identificato 15 peptidi, definiti come indicatori caratteristici
di CAD, in un sottogruppo di pazienti ed ha poi verificato la capacità
predittiva del modello: il profilo polipeptidico così stabilito
era in grado di predire la presenza della patologia nell'83% dei casi
(IC al 95% 51,6-94,4), con una sensibilità del 98% (89-99). I risultati
suggeriscono che questo approccio può essere utilizzato per determinare
gli stadi precoci della patologia; inoltre la misurazione di questi 15
polipeptidi può essere sfruttata nel monitoraggio della progressione
di CAD.
[URINARY PROTEOMIC BIOMARKERS IN CORONARY ARTERY DISEASE.
Mol Cell Proteomics 2008; 7:290-298]
LP-PLA2
E CORONAROPATIA
Lp-PLA2
è un nuovo enzima probabilmente coinvolto nella formazione di placche
vulnerabili e circola nel sangue legato al colesterolo LDL. È altamente
espresso dai macrofagi all'interno del nucleo necrotico e del cappuccio
fibroso della placca ed ha un ruolo primario nell'idrolisi dei fosfolipidi
ossidati, che porta alla formazione di prodotti proinfiammatori e proaterogenici.
In questo studio è stata indagata l'associazione tra Lp-PLA2
e coronaropatie (CHD) in uomini apparentemente sani. Sono stati inclusi
nell'analisi 1077 uomini e donne (età media 72 anni) senza CHD
al basale e sono stati seguiti per 16 anni. I livelli di Lp-PLA2
correlavano positivamente con colesterolo totale, LDL e trigliceridi e
negativamente con il colsterolo HDL. Correlazioni deboli ma significative
sono state osservate con pressione sistolica, proteina C-reattiva e indice
di massa corporea. Dopo aggiustamenti per età, sesso e parametri
biochimici, elevati livelli di Lp-PLA2 erano significativamente
associati al rischio di CHD incidenti.
[LIPOPROTEIN-ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2 IS AN INDEPENDENT
PREDICTOR OF INCIDENT CORONARY HEART DISEASE IN AN APPARENTLY HEALTHY
OLDER POPULATION: THE RANCHO BERNARDO STUDY. J Am Coll Cardiol 2008; 51:913-919]
SINDROME
METABOLICA E FIBRILLAZIONE ATRIALE
I
soggetti con sindrome metabolica (SM) hanno un rischio aggiustato per
sesso e per età maggiore di almeno il 60% di sviluppare fibrillazione
atriale (AF) in 4,5 anni. Questi risultati sono stati ottenuti in uno
studio di coorte prospettico condotto in Giappone su più di 28.000
persone. La prevalenza al basale di SM era pari al 13% per i criteri del
National Cholesterol Education Program Third Adult Treatment Panel (NCEP-ATP
III) e al 16% per le linee guida dell'American Heart Association/National
Heart, Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI). Il rischio aggiustato di
AF cresceva del 10% per ogni anno d'età e negli uomini era triplicato
rispetto alle donne, perciò l'analisi multivariata è stata
corretta per età e sesso. Ne è emerso significativo aumento
degli hazard ratios per entrambe le definizioni: 1,88 (NCEP-ATP III) e
1,61 (AHA/NHLBI). Lo studio ha anche rilevato che il rischio di AF cresceva
col numero di determinanti di SM e che ciascun determinante risultava
predittivo di AF.
[METABOLIC SYNDROME AND RISK OF DEVELOPMENT OF ATRIAL FIBRILLATION.
THE NIIGATA PREVENTIVE MEDICINE STUDY. Circulation, pubblicato on line
il 19 febbraio 2008]
STRESS
LAVORATIVO E MALATTIE CORONARICHE
Lo
stress sul lavoro può influenzare lo sviluppo di CHD attraverso
l'attivazione diretta delle risposte neuroendocrine allo stress, o indirettamente
con l'induzione di atteggiamenti non salutari come il fumo, lo scarso
esercizio fisico o l'eccessivo consumo di alcool. Uno dei principali assi
di risposta neuroendocrina allo stress è il sistema nervoso autonomo:
la sua ripetuta attivazione è caratterizzata da ridotta variabilità
della frequenza cardiaca. L'altro sistema interessato è l'asse
ipotalamico-pituitario-adrenergico, associato a disturbi della variazione
circadiana dei livelli di cortisolo e allo sviluppo di sindrome metabolica.
Una nuova ricerca britannica su 10.308 uomini e donne ha rilevato lo stress
lavorativo e parametri quali fattori di rischio comportamentali, sindrome
metabolica, variabilità della frequenza cardiaca, aumento dei livelli
di cortisolo al mattino e CHD incidenti. Lo stress lavorativo era associato
a patologia coronarica e questa associazione era più forte tra
i partecipanti con più di 50 anni (RR 1,68; IC al 95% 1,17-2,42).
[WORK STRESS AND CORONARY HEART DISEASE: WHAT ARE THE MECHANISMS?
Eur Heart J, pubblicato on line il 23 gennaio 2008]
|
|
CONSUMO
DI CARNE E RISCHIO DI IPERTENSIONE IN DONNE DI MEZZA ETÀ E ANZIANE
Osservazioni
epidemiologiche negli anni passati hanno suggerito che il passaggio da
una dieta controllata, ricca in cereali non raffinati, verdura e pesce,
ad una dieta occidentale, con grassi saturi e carne grassa, può
aumentare la pressione arteriosa e l'incidenza di ipertensione. Un elevato
consumo di carne, soprattutto rossa, può indipendentemente contribuire
allo sviluppo di ipertensione a causa del contenuto in grassi saturi,
proteine animali, colesterolo e altri componenti. Questo studio ha analizzato
l'associazione prospettica tra il consumo di diversi tipi di carne e lo
sviluppo a 10 anni della condizione ipertensiva in 28.766 donne con età
>=45 anni. I risultati hanno mostrato che la carne rossa era associata
ad un aumento del rischio di ipertensione; tale associazione era particolarmente
forte per donne con valori pressori basali nella norma. Per contro non
sono state rilevate associazioni con la carne di pollame.
[MEAT INTAKE AND THE RISK OF HYPERTENSION IN MIDDLE-AGED
AND OLDER WOMEN. J Hyper 2008; 26:215-222]
CONSUMO
DI ALCOLICI NEL CORSO DELLA VITA E RISCHIO CARDIOMETABOLICO
Nella
maggioranza degli studi sugli effetti dell'alcol sulla salute, il consumo
di alcolici viene rilevato in un singolo momento, assumendo che le modalità
di assunzione siano circa le stesse per tutta la vita. Questi studi non
possono caratterizzare adeguatamente l'esposizione all'alcol per tutta
la vita degli individui. A questo scopo è stato sviluppato il Cognitive
Lifetime Drinking History (CLDH), un'intervista computerizzata formulata
per ricostruire retrospettivamente il pattern di consumo di alcolici negli
studi sulle condizioni croniche correlate all'alcol. In questo studio,
sono stati usati i dati ottenuti con il CLDH su 2818 soggetti, per indagare
le caratteristiche delle diverse modalità di uso di alcolici e
l'associazione con i determinanti della sindrome metabolica (SM). Sono
stati identificati due distinti pattern nel corso della vita, uno caratterizzato
da un forte consumo nella giovinezza seguito da una drastica riduzione,
l'altro contraddistinto da un consumo moderato più o meno costante.
Non c'erano differenze significative nella prevalenza di SM; tuttavia,
nell'analisi di regressione multipla, picchi di consumo in giovane età
erano associati a odds di SM più alti rispetto ad un consumo stabile.
[ASSOCIATION OF LIFETIME ALCOHOL DRINKING TRAJECTORIES
WITH CARDIOMETABOLIC RISK. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93:154-61]
SOFT
DRINKS E RISCHIO DI GOTTA NEGLI UOMINI
La
gotta, la più comune forma di artrite infiammatoria negli uomini,
è sempre più diffusa. Il raddoppio della prevalenza e dell'incidenza
negli Stati Uniti è coinciso con un sostanziale incremento nel
consumo di soft drink dolcificati col fruttosio. In genere le raccomandazioni
dietetiche relative alla malattia si concentrano sulla riduzione del consumo
di purina e alcol, non sui soft drink dolcificati che contengono fruttosio,
uno dei nutrienti in grado di aumentare i livelli di acido urico. Non
è noto se il suo effetto acuto abbia valore a lungo termine e quanto
incida sul rischio di gotta. Per indagare tale associazione è stato
condotto uno studio prospettico su 46.393 soggetti maschi, senza precedenti
della malattia, che hanno risposto a domande sul consumo di soft drink
e fruttosio, nell'arco di dodici anni. I risultati hanno mostrato che
il rischio è più alto dell'85% con due o più bicchieri
di soft drink a settimana rispetto a chi consuma meno di un bicchiere
al mese, indipendentemente da altri fattori scatenanti come età,
peso, consumo di alcol.
[SOFT DRINKS, FRUCTOSE CONSUMPTION, AND THE RISK OF GOUT
IN MEN: PROSPECTIVE COHORT STUDY. BMJ 2008; 336:309-12]
APPORTO
DIETETICO DI VITAMINA B3 E CANCRO COLORETTALE
La
vitamina B6 è coinvolta nelle vie metaboliche del folato, che è
stato correlato alla carcinogenesi colorettale. Pochi studi osservazionali
hanno indagato l'associazione tra l'apporto di vitamina B6 e il cancro
del colon retto e solo alcuni considerano l'assunzione tramite integratori
parallelamente a quella tramite dieta. L'obiettivo di questo ampio studio
caso-controllo era valutare l'effetto dell'apporto dietetico e supplementare
di vitamina B6 sul cancro colorettale in un campione di 4750 soggetti
ed esaminare l'effetto di tre polimorfismi coinvolti nel metabolismo del
folato sulla vitamina B6 e sull'associazione col cancro. Lo studio ha
dimostrato l'esistenza di un link dose-dipendente tra l'assunzione della
B6 e il rischio di cancro del colon-retto; più precisamente, si
è visto che al confronto tra due gruppi di persone, uno composto
da soggetti già portatori del cancro e uno da soggetti sani di
controllo, si verificava una riduzione del rischio pari al 19% nella popolazione
che abitualmente dichiarava un'assunzione dietetica elevata di vitamina
B6.
[DIETARY
VITAMIN B6 INTAKE AND THE RISK OF COLORECTAL CANCER. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev 2008; 17:171-182]
|
|
INDICE
DI MASSA CORPOREA E INCIDENZA DI CANCRO
Il
legame esistente tra il rischio di cancro e l'eccesso ponderale è
diventato sempre più evidente nel corso degli ultimi anni, ma il
sovrappeso aumenta il rischio in modo diverso in uomini e donne. Per analizzare
questa associazione, è stata condotta una review sistematica, che
ha raccolto i dati di 221 studi tra il 1966 e il 2007, per un totale di
282.137 casi incidenti di cancro. Dai risultati emerge che nelle donne
l'eccesso di peso aumenta soprattutto il rischio di cancro al collo dell'utero,
alla vescica biliare e al pancreas, come anche quello al seno dopo la
menopausa. Negli uomini, è stata evidenziata una relazione tra
sovrappeso e tumore alla pelle, leucemia e tumori ai linfonodi. Non si
evidenzia invece una differenza tra uomini e donne per quanto riguarda
la possibilità di avere un cancro all'esofago, alla tiroide, ai
reni e all'intestino.
[BODY-MASS INDEX AND INCIDENCE OF CANCER: A SYSTEMATIC
REVIEW AND META-ANALYSIS OF PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDIES. The Lancet
2008; 371:569-578]
FATTORI
DI RISCHIO PER LA PSORIASI
Negli
ultimi anni è diventato chiaro che la psoriasi è una patologia
di natura infiammatoria dovuta ad alterazioni del sistema immunitario
e molte indagini sono state condotte per identificarne i fattori di rischio.
Uno studio caso-controllo multicentrico ha arruolato 560 casi e 690 controlli
e ha indagato le correlazioni con alcune condizioni patologiche. I risultati
hanno evidenziato forti correlazioni tra psoriasi e alcune malattie croniche,
come diabete, ipertensione o iperlipidemia. Un'altra condizione di natura
infiammatoria a cui la psoriasi è stata associata è la sindrome
metabolica (SM). Per valutare tale associazione è stato condotto
uno studio trasversale su 16.851 soggetti con psoriasi e 48.618 controlli.
Modelli multivariati aggiustati per età, sesso e abitudine al fumo
hanno dimostrato che la psoriasi era associata alla presenza di sindrome
metabolica (OR=1,3, IC al 95%=1,1-1,4).
[MEDICAL HISTORY, DRUG EXPOSURE AND THE RISK OF PSORIASIS.
EVIDENCE FROM AN ITALIAN CASE-CONTROL STUDY. Dermatology 2008; 216:125-30];
[ASSOCIATION BETWEEN PSORIASIS AND THE METABOLIC SYNDROME. A CROSS-SECTIONAL
STUDY. Dermatology 2008; 216:152-5]
|